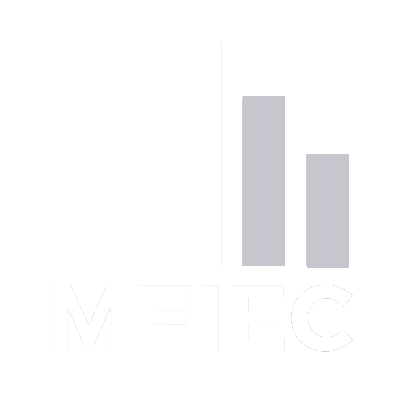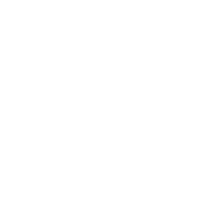Anita Quas, Daniela Vandone
Università degli Studi di Milano
Nel corso delle ultime due decadi, la missione di Cassa Depositi e Prestiti si è ampliata, suscitando tuttavia qualche criticità della quale occorre essere consapevoli.
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’istituzione finanziaria italiana a controllo pubblico nata nel 1850 con l’obiettivo di raccogliere i risparmi dei cittadini italiani, principalmente attraverso i libretti e i buoni postali, al fine di finanziare opere pubbliche come scuole, strade e impianti fognari.
Dalla sua costituzione, CDP ha sempre svolto un ruolo di primo piano nel panorama economico e sociale italiano, con la sua funzione anticiclica volta a sostenere la crescita economica e l’occupazione nei periodi di congiuntura negativa e la sua offerta di capitale “paziente” per finanziare progetti socialmente utili ma non immediatamente redditizi e, dunque, poco attraenti per i finanziatori privati.
Negli ultimi due decenni, però, ha conosciuto importanti trasformazioni. Da un lato, la parziale privatizzazione del 2003 e trasformazione in società per azioni (S.p.A.) ha permesso a CDP di rafforzare gli strumenti a sostegno di imprese e progetti di interesse pubblico, tra cui la possibilità di acquisire partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale. Dall’altro, il riconoscimento ufficiale dello status di “banca di sviluppo nazionale” italiana avvenuto nel 2015 da parte della Commissione Europea ha reso CDP il partner finanziario pubblico in Italia per la realizzazione delle politiche di investimento europee e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite, tra cui i progetti di transizione energetica. Il ruolo di CDP si è rivelato poi particolarmente strategico durante la pandemia di COVID-19, quando ha implementato strumenti volti a garantire liquidità e accesso al credito al sistema industriale italiano, sostenendo il sistema economico nazionale in un momento di particolare difficoltà.
Nonostante vi siano molti elementi positivi legati all’operatività di CDP, l’operatività delle banche di sviluppo è per natura esposta a delle potenziali criticità. La letteratura economica, infatti, riconosce il valore delle banche di sviluppo nel mitigare i fallimenti del mercato, ma pone l’accento anche sui rischi legati a un intervento pubblico diretto. In particolare, il principale timore è che l’influenza politica e l’inefficienza tradizionalmente tipica delle istituzioni pubbliche possano portare a una gestione distorta degli investimenti, riducendo il valore creato.
In Italia, i politici di diversi orientamenti hanno avuto un ruolo significativo nell’espansione della missione di CDP, rendendo concreta questa preoccupazione. Al tempo stesso, il sistema di corporate governance di CDP e la sostanziale professionalizzazione del suo management, a partire in particolare dalla trasformazione in società per azioni nel 2003, hanno svolto un ruolo importante nella creazione di barriere formali all’ingerenza politica nelle decisioni di CDP in merito alla gestione delle risorse finanziarie.
La trasformazione in S.p.A. ha infatti introdotto un consiglio di amministrazione composto da undici membri, di cui almeno due indipendenti dunque privi di legami con CDP, il suo management e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), analogamente a quanto previsto dalla normativa per le imprese private. Il CdA è responsabile delle decisioni operative, mentre l’intervento del MEF è limitato alla sola definizione degli obiettivi generali. Inoltre, la struttura organizzativa è evoluta in un gruppo con una holding centrale e delle controllate operative specializzate, che lavorano in ambiti specifici. Infine, l’assetto proprietario è stato modificato con l’ingresso di attori privati: il 30% delle azioni è ora detenuto da 65 fondazioni bancarie, che hanno diritti privilegiati e nominano un terzo del consiglio. Questo sistema, nel suo complesso, garantisce un certo equilibrio, limitando le pressioni politiche, sebbene introduca il rischio che l’attenzione del management si sposti su obiettivi di breve periodo a scapito della finalità pubblica di CDP.
Nonostante i progressi significativi nella governance e la capacità di mantenere il suo ruolo di banca di sviluppo, l’ampliamento della missione di CDP – che ha portato l’istituzione a intraprendere funzioni che sembrano meno allineate alla sua missione originale, come il sostegno a imprese in difficoltà finanziaria e il ruolo di holding – solleva interrogativi, ancora aperti, sull’equilibrio tra il perseguimento degli obiettivi pubblici e l’adozione di strategie più orientate al mercato, che possono comportare uno spostamento delle priorità verso obiettivi di redditività economica, sacrificando in parte la sua funzione pubblica.
Un approfondimento di queste tematiche è disponibile nell’articolo originale, pubblicato su Review of Political Economy nell’aprile del 2024.